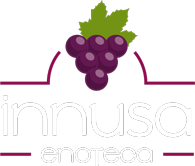Il rapporto tra il vino e l’ossigeno
Il rapporto che si viene a creare tra il vino e l’ossigeno che è naturalmente presente all’interno dell’aria determina e influenza la qualità di questo prodotto ben più di quanto si potrebbe credere. In particolare si possono considerare tre diversi momenti in cui questo gas ha un’influenza, in positivo o in negativo, sul vino: durante i vari processi di vinificazione, in conservazione e al momento dell’assaggio.
Cos’è l’ossidazione
L’ossidazione è la reazione chimica che si viene a creare quando la molecola dell’ossigeno dell’aria entra in contatto con le diverse sostanze organiche disciolte all’interno del vino. A causa di tali interazioni, infatti, avvengono una serie di trasformazioni che comportano importanti cambiamenti visivi, gustativi e olfattivi. Sono proprio questi a determinare il livello qualitativo percepito del vino.
Cosa accade durante i processi produttivi
L’ossidazione può alterare e danneggiare enormemente il vino durante le varie fasi della sua produzione perciò molto spesso si decide di aggiungervi degli additivi che catturano l’ossigeno e bloccano la sua attività.
Un classico esempio è rappresentato dai solfiti che, a seguito di queste reazioni, si trasformano in solfati e, poi, in anidride solforosa che si allontana dal vino per evaporazione spontanea. Prima di procedere all’imbottigliamento si deve verificarne il suo contenuto residuo perché sia al di sotto di 160 mg/l nei rossi e 210 mg/l nei bianchi (si tratta di valori imposti per legge).
Per ridurre il rischio di ossidazione i produttori di vino hanno anche l’accortezza di riempire il più possibile sia i tini durante la vinificazione sia ogni singola bottiglia.
L’influenza dell’ossigeno durante la conservazione
L’ossigeno causa importanti trasformazioni nel vino durante il suo periodo di invecchiamento. Questi cambiamenti sono visibili anche ad occhio nudo perché i vini bianchi tenderanno ad assumere dei toni più dorati all’inizio e poi sempre più scuri, fino a virare al marroncino. Nei vini rossi, invece, le sfumature passeranno al color mattone fino ad arrivare quasi all’arancione.
Anche i profumi che sprigionano si modificano a causa dell’ossigenazione perché i tannini scompariranno progressivamente rendendo il vino più piatto.
Attenzione particolare deve essere posta anche al livello di acidità del prodotto perché i batteri acetici presenti nel vino operano in ambiente aerobio perciò la presenza dell’ossigeno favorisce la loro azione con formazione di acido acetico (è quello che accade quando si dice che il vino si è trasformato in aceto).
Tutti questi cambiamenti sono irreversibili perciò una volta accaduti non è più possibile tornare indietro.
Da queste premesse si capisce perché è fondamentale, oltre al livello di riempimento della bottiglia, anche che il suo tappo sia perfettamente a tenuta per evitare l’ingresso di nuovo gas.
L’ossigenazione di un vino invecchiato al momento dell’assaggio
Quando, finalmente, stappiamo una bottiglia di vino invecchiato è, invece, importante che il prodotto entri a contatto con l’ossigeno perché in questo modo riuscirà ad esaltare tutte le sue caratteristiche e proprietà. Ecco perché è sempre consigliato non degustare immediatamente una bottiglia subito dopo averla stappata, ma lasciarla aerare per un tempo che di solito è indicato da ogni singolo produttore. Ogni vino, infatti, richiede un periodo di ossigenazione differente.
Il modo migliore per favorire il contatto vino-ossigeno sarebbe quello di utilizzare un decanter all’interno del quale travasare la bottiglia. Si tratta di un contenitore in vetro trasparente dalla forma allargata alla base e ristretta in superficie che permette proprio una corretta ossigenazione. Così facendo, poi, si ha anche il vantaggio di poter verificare se si sono formati dei depositi durante l’invecchiamento e non versarli nel bicchiere.